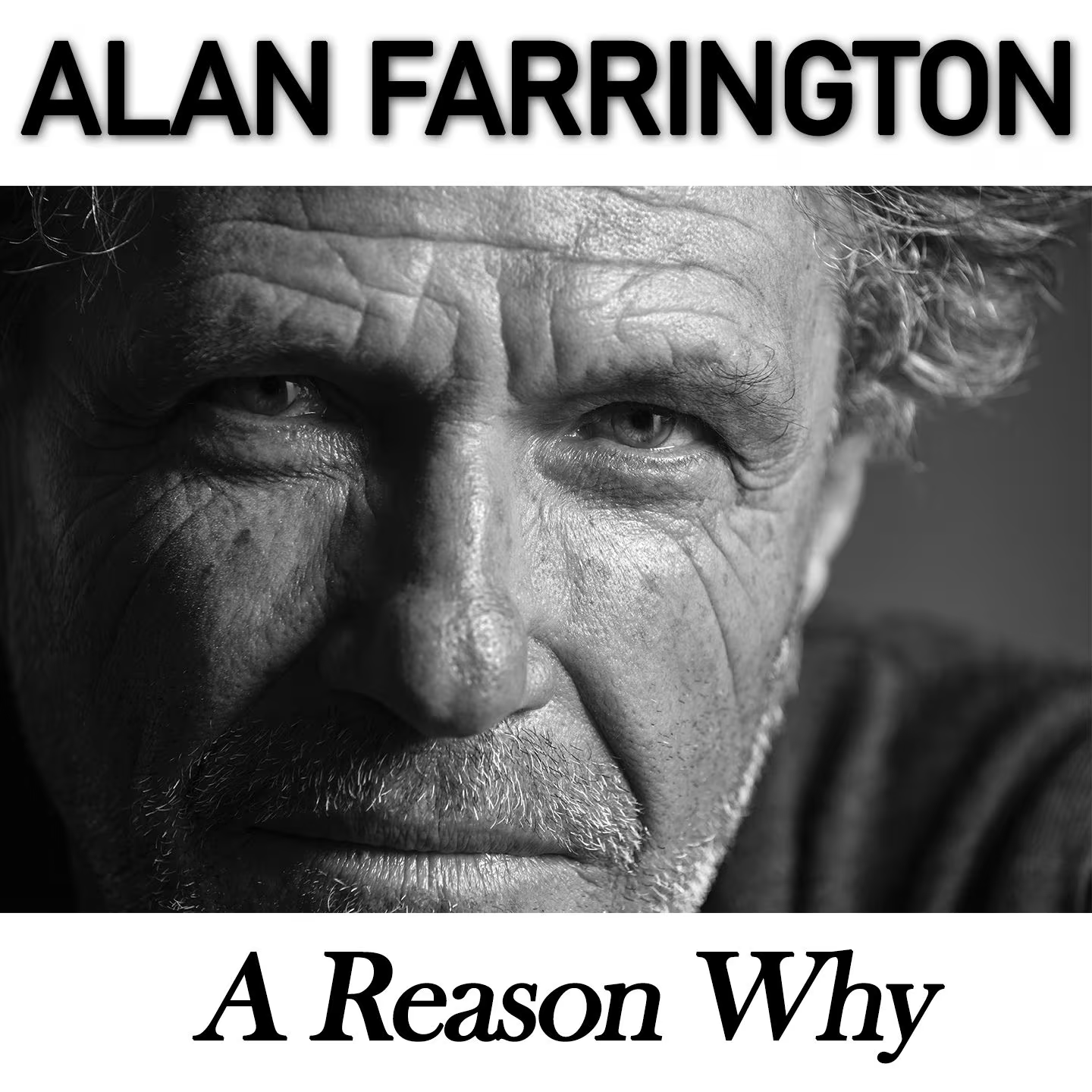C’è un’anima che pesa appena 21 grammi ma riesce a contenere tutto: il desiderio, la perdita, la madre, la memoria, la Sicilia. Giuseppe Cucè ci accompagna lungo un sentiero intimo e fragile. “È tutto così vero” è la carne che si apre al disincanto. “Ventuno” ci parla da dentro, con la voce dell’anima che non chiede prove. “Dimmi cosa vuoi” è il tentativo riuscito di salvarsi a vicenda. Poi l’equilibrio si rompe, e “Fragile equilibrio” diventa la fotografia più pura di ciò che siamo. “La mia dea” è un brano fatto di ricordi e carezze. Il lato B è il lato dell’inverno, in tutti i sensi. “Cuore d’inverno” pulsa con freddezza consapevole. “Tutto quello che vuoi” ci mette davanti a uno specchio distorto. “Una notte infinita” sospende il tempo. E “Di estate non si muore” è una preghiera laica per una terra ferma. Un album che non consola, ma accompagna.
Da dove sei partito per scrivere i testi di questo album così intimo e denso?
Sono partito da una frattura. Dalle crepe. Da quel momento in cui smetti di raccontarti storie e inizi a guardarti davvero. Ogni brano è nato da una necessità, non da un’idea. Non ho cercato le parole: sono venute a galla mentre cercavo di attraversare le mie ombre, di fare pace con il dolore, con la memoria, con la bellezza imperfetta di ciò che siamo. È un album scritto più con la pelle che con la penna.
“Fragile equilibrio” è un brano potente e visivo. Quanto è autobiografico e quanto è frutto di osservazione?
È entrambe le cose. È mio, ma potrebbe appartenere a chiunque. L’ho scritto pensando a certe notti in cui tutto vacilla, eppure qualcosa dentro continua a reggere.
C’è un’idea di riflesso, come nello specchio di Dorian Gray: ciò che vediamo spesso è un’immagine distorta o idealizzata, che non coincide con la nostra verità più profonda.
Viviamo circondati da specchi che restituiscono versioni di noi che non ci appartengono davvero.
Il fragile equilibrio, però, non è nell’apparenza, ma nella scelta di accettare le proprie crepe, la propria imperfezione.
Solo quando smetti di rincorrere l’immagine e inizi a riconoscere la tua fragilità come forza, ritrovi la tua misura. E forse anche un po’ di pace.
Nei tuoi testi c’è una tensione tra il corpo e l’anima. Come riesci a mantenere questo equilibrio nelle parole?
Non cerco un equilibrio perfetto, ma un dialogo sincero tra i due. Il corpo è la mia prima voce, l’anima è ciò che resta quando la voce si spegne. Cerco di scrivere come si danza: con carne e spirito insieme. Ogni parola deve avere un peso e un respiro. Non credo nei testi “perfetti”, credo in quelli che tremano, che pulsano, che restano addosso.
In “Dimmi cosa vuoi” parli d’amore con una forza quasi fisica: come riesci a tradurre il sentimento in immagine?
L’amore, quando è vero, è corpo. È urto, è fame, è silenzio che brucia. Cerco immagini che non siano solo estetiche, ma emotive. Non mi interessa raccontare l’amore “giusto”, ma quello che ci cambia le ossa. Scrivo come se stessi fotografando l’interno di uno sguardo, o il momento esatto in cui due corpi si sfiorano e qualcosa esplode.
Usi molte metafore ma non perdi mai la concretezza: qual è il tuo approccio alla scrittura poetica?
La poesia, per me, è radicata nella carne. Uso la metafora come un bisturi: serve a incidere, non a nascondere. Mi interessa che ogni immagine sia viva, che abbia un odore, una temperatura. Scrivere è come scavare: uso la parola per arrivare sotto la pelle delle cose, per toccare l’umano. La poesia non è fuga dalla realtà. È il suo cuore più nudo.